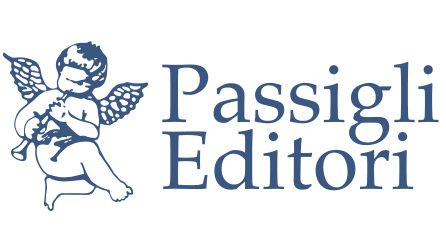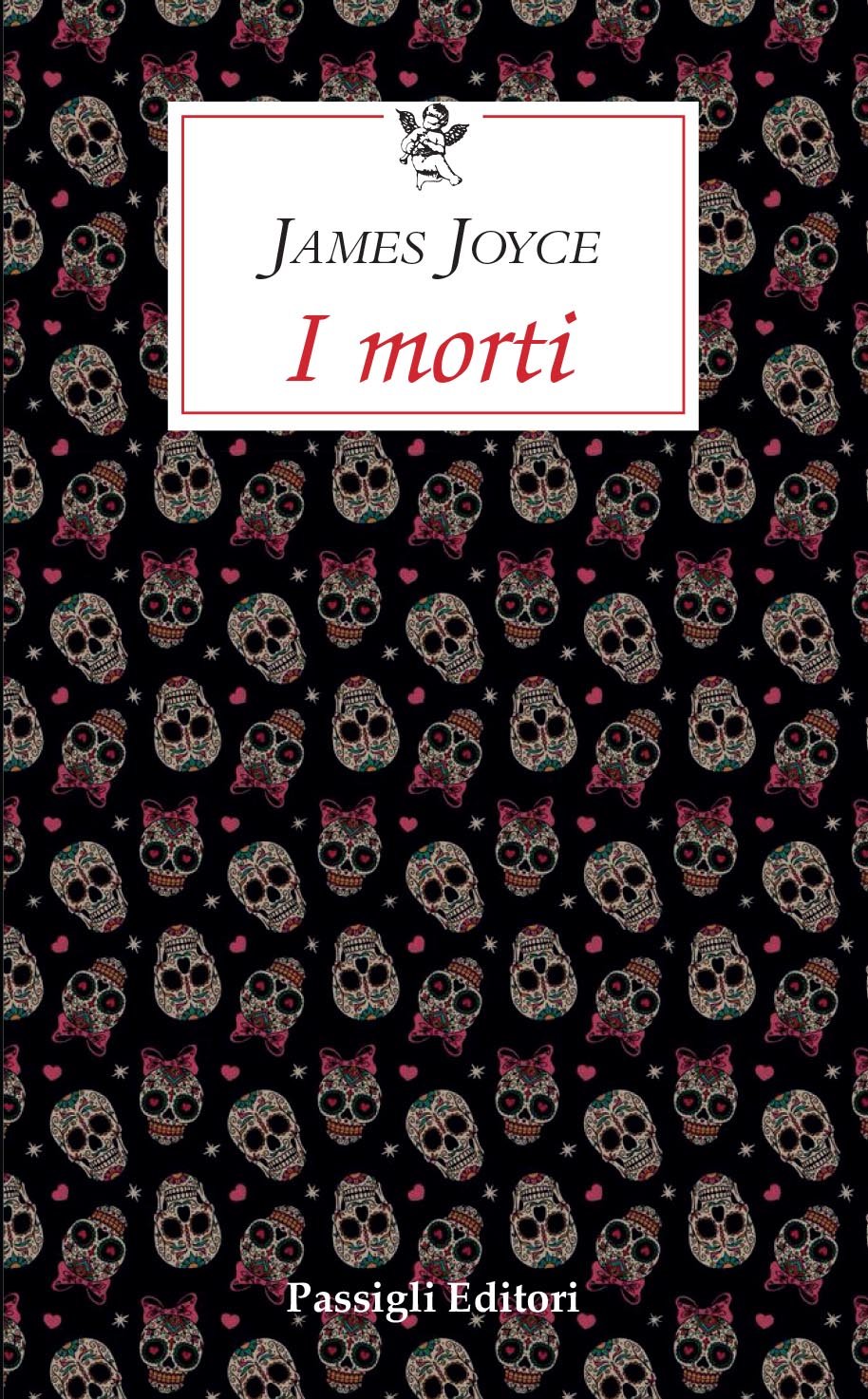Un leggero picchiettio ai vetri lo fece girare verso la finestra. Aveva ricominciato a nevicare.
Con aria assonnata guardava i fiocchi, d’argento e scuri, cadere di sbieco contro il lampione. Era arrivato per lui il momento di mettersi in viaggio verso occidente. Sì, i giornali avevano ragione: c’era neve ovunque in Irlanda.
Cadeva su ogni parte dell’oscura pianura centrale, sulle colline senz’alberi, cadeva soffice sulla Bog of Allen53 e, più a occidente, soffice cadeva nelle oscure turbolenti acque dello Shannon54.
Cadeva anche sopra ogni parte del cimitero solitario sulla collina dove giaceva sepolto Michael Furey. Si accumulava sulle croci storte e sulle lapidi, sulle lance del cancello, sulle spine dei rovi spogli.
Lenta l’anima gli veniva meno mentre sentiva la neve cadere fievole per tutto l’universo e fievole cadere, come la discesa della loro estrema fine, su tutti i vivi e i morti.
Ci sono racconti che non invecchiano mai. Parlano di feste d’altri tempi, di vestiti fuori moda, di case illuminate a gas e di conversazioni convenzionali. Eppure, dietro questa patina, hanno ancora il potere di scuoterci, di toccare corde intime che non cambiano con i secoli. I morti (The Dead), ultimo e più lungo racconto dei Dubliners di James Joyce, è uno di questi. Pubblicato nel 1914, chiude la raccolta come un colpo di teatro: con la sua neve che cade lenta su tutta l’Irlanda, racconta la vita, l’amore e la memoria con una delicatezza che diventa universale.
La trama de “I Morti”: una festa che non è solo una festa
La storia si apre la sera del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nella casa delle sorelle Morkan, dove si tiene il consueto ricevimento natalizio. Tutto sembra scorrere secondo tradizione: canti, danze, brindisi, piccoli screzi di famiglia. In apparenza, una tipica serata borghese della capitale irlandese di inizio Novecento.
Protagonista è Gabriel Conroy, intellettuale, insegnante e giornalista, invitato con la moglie Gretta. Gabriel è convinto di avere il controllo della situazione: prepara con cura un discorso per le padrone di casa, si sente brillante, superiore, ironico. Ma la realtà lo smentisce più volte: la cameriera Lily lo accoglie con un’ironia pungente che lo mette subito a disagio, una vecchia conoscente lo punzecchia per le sue scelte culturali “anglofile”, il suo brindisi risulta meno incisivo del previsto.
La festa, insomma, non lo celebra: lo mette a nudo. Ogni dettaglio che Joyce inserisce – un sorriso mancato, un dialogo maldestro, un applauso più tiepido del previsto – mina la sicurezza del protagonista.
Eppure il colpo più duro arriva dopo la festa. In albergo, Gabriel osserva la moglie assorta e commossa, mentre ascolta una vecchia melodia. È “The Lass of Aughrim”, una canzone che riporta Gretta al ricordo di un amore giovanile: Michael Furey, un ragazzo malato e fragile che, pur di vederla un’ultima volta, uscì sotto la pioggia e morì poco dopo.
Di fronte a questa rivelazione, Gabriel è travolto da un’epifania: tutta la sua vita, vissuta in equilibrio e prudenza, appare improvvisamente vuota, tiepida. L’amore che Michael ha provato per Gretta – intenso, assoluto, fino alla morte – gli rivela la sua stessa inadeguatezza.
Il racconto si chiude con l’immagine che resta scolpita nella memoria di chi legge: la neve che cade su tutta l’Irlanda, sui vivi e sui morti, unendo ciò che è presente e ciò che è perduto.
Joyce: un racconto ha radici personali
Dietro la trama, c’è molto della vita di Joyce stesso. Secondo gli studiosi, Gabriel Conroy porta in sé molte delle insicurezze dell’autore: il suo sentirsi diviso tra Irlanda e Inghilterra, il timore di non essere davvero compreso dai connazionali, il desiderio di affermarsi come intellettuale.
Ma non è solo Gabriel a riportare echi autobiografici. La casa in cui si svolge la festa, ad esempio, è ispirata a un luogo reale: al numero 15 di Usher’s Island, a Dublino, abitava la prozia di Joyce, che organizzava serate molto simili a quelle descritte nel racconto. Ancora oggi la casa è meta di visite e tour letterari, segno di quanto The Dead sia radicato nella città.
Anche la figura di Michael Furey sembra nascere da un ricordo personale: la giovane Nora Barnacle, futura moglie di Joyce, aveva raccontato all’autore di un suo amore adolescenziale morto prematuramente. Un dettaglio biografico che Joyce trasformò in un simbolo universale, capace di colpire chiunque legga la storia.
I morti di Joyce: curiosità che non tutti sanno
- Un racconto lungo quanto un romanzo breve: con le sue oltre 15.000 parole, The Dead è il più esteso dei Dubliners e occupa da solo più di un quarto del libro.
- Il tema della musica: la canzone “The Lass of Aughrim” non è inventata, ma fa parte del repertorio popolare irlandese. Joyce la inserisce come detonatore narrativo: senza quella melodia, il passato non tornerebbe a galla.
- Ripetizioni e ossessioni: gli studiosi hanno notato come Joyce usi la ripetizione di parole e gesti per creare un senso di immobilità, quasi di morte, già nella vita quotidiana dei personaggi. Non a caso, il titolo non si riferisce solo a chi è realmente morto, ma anche a chi vive senza intensità.
- Dal libro al cinema: nel 1987 John Huston, già gravemente malato, scelse proprio The Dead come suo ultimo film, con Anjelica Huston, Colm Meaney. Girato quasi interamente in interni, il film è un atto d’amore per la letteratura e per il tema stesso della memoria.
Perché leggerlo oggi
Potrebbe sembrare un racconto lontano da noi: feste formali, dialoghi pieni di convenzioni, atmosfere di un’altra epoca. Eppure, The Dead è più attuale che mai.
Joyce ci parla della differenza tra sopravvivere e vivere davvero. Ci mostra come la memoria e i legami con chi non c’è più possano pesare più del presente, ma anche come l’epifania – il momento in cui vediamo tutto con chiarezza – possa aprirci a una consapevolezza nuova.
Consiglio da lettore: procurati la nostra edizione Passigli con la prefazione di Alessandro Gentili – curata e fedele – e lasciati trasportare. Che tu lo legga per la prima volta o che ci torni dopo anni, non ti lascia mai indifferente. Perché dietro la neve che cade sui vivi e sui morti c’è la domanda più semplice e più urgente: stiamo davvero vivendo, o ci stiamo solo lasciando trascinare?