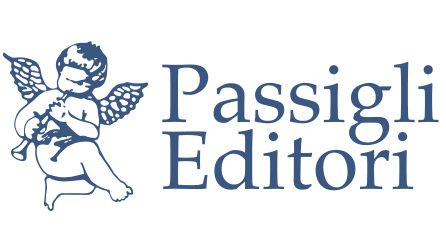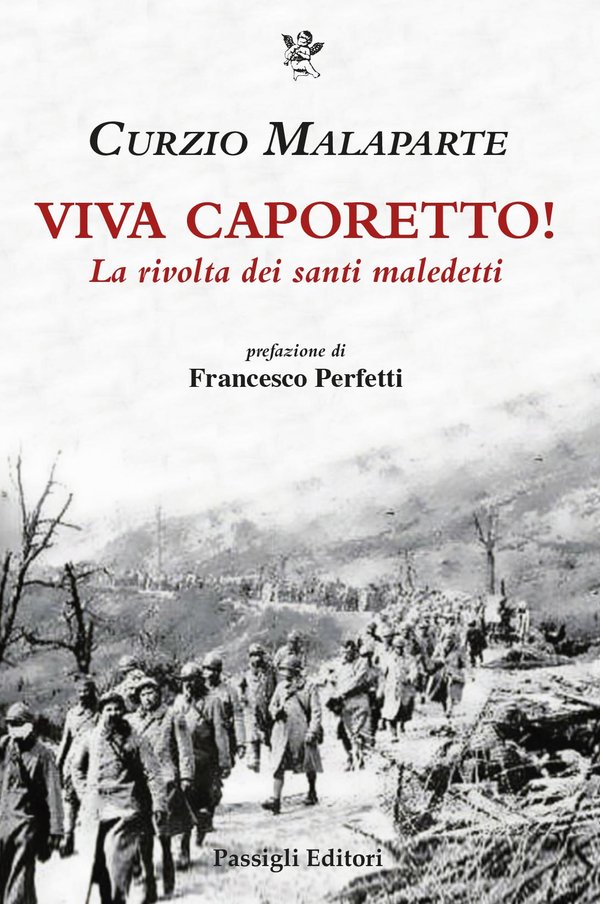La disfatta di Caporetto: un libro di Malaparte per riflettere sulla storia italiana
Cosa accadde a Caporetto, alla fine del 1917? Di chi fu la “colpa” di quella clamorosa sconfitta, con lo sfondamento delle nostre linee da parte dell’esercito austro-ungarico? E quali effetti ebbe, sul breve e medio periodo, una disfatta militare di quelle proporzioni?
Per cercare di rispondere abbiamo scelto un autore davvero sui generis, dalla penna raffinata ma non ancora del tutto esplorato: Curzio Malaparte, al secolo Kurt Erich Suckert, e cioè una delle figure più emblematiche e controverse della scena letteraria italiana della prima metà del Novecento.
Abbiamo arricchito il nostro catalogo con un suo libro, Viva Caporetto! La rivolta dei santi maledetti con una prefazione da parte di Francesco Perfetti, uno dei massimi storici italiani.
In quelle pagine, e per la prima volta, venne offerta un’originale chiave di lettura su quanto accaduto, con l’attribuzione della responsabilità ultima all’incompetenza del Comando Supremo, e non invece ai semplici soldati (“i santi maledetti”), ingiustamente accusati di viltà dal generale Cadorna e fin ad allora considerati i veri artefici di una débâcle senza precedenti.
Approfondiamo insieme!
Cosa fu la disfatta di Caporetto del 1917
La disfatta di Caporetto rappresenta uno dei momenti più controversi della Grande Guerra (1915-1918), un evento che ha segnato profondamente la storia dell’esercito italiano lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.
Il Corriere della Sera, principale quotidiano della borghesia italiana, e già schierato nel campo interventista alla vigilia della guerra, il 27 ottobre 1917, all’indomani dello sfondamento da parte delle truppe avversarie, e pur nella difficoltà oggettiva di reperire informazioni complete, scrisse un articolo dal titolo indicativo: “La violenza dell’offensiva austro-ungarica”.
Si leggeva a metà pagina:
Non è possibile far previsioni. La lotta è più che aspra; le sue vicende incerte; il nemico forte di un’artiglieria numerosissima e del vantaggio da noi più volte sperimentato che è consentito a chi attacca. La situazione creata dal poderoso urto nemico è indubbiamente grave.
Le conseguenze di Caporetto, di lì, furono innumerevoli. L’Italia perse un vasto territorio, tra cui gran parte della regione del Friuli, con l’esercito costretto a ritirarsi fino al fiume Piave.
Circa 10.000 soldati italiani vennero uccisi, 30.000 feriti e circa 265.000 fatti prigionieri; con 400.000 dispersi. Il morale dell’esercito precipitò e, inevitabilmente, continuarono episodi di insubordinazione.
In questo quadro, Luigi Cadorna, capo di stato maggiore dell’esercito, puntò il dito contro i soldati italiani.
Mentre il paese era attonito di fronte all’accaduto e si rafforzavano le correnti nazionaliste, Cadorna attribuì gran parte della colpa per la disfatta di Caporetto alla mancanza di disciplina e alla scarsa resistenza delle truppe, sostenendo che molti soldati si erano arresi facilmente al nemico oppure avevano disertato.
Cadorna fu sostituito da Armando Diaz nel novembre 1917, che, anche grazie all’aiuto degli alleati, condusse l’Italia alla vittoria, nel 1918.
Eppure, le discussioni, le polemiche e gli strascichi relativi alla disfatta di Caporetto – un evento cruciale della storia italiana – non cessarono con la fine della guerra.
I “santi maledetti” e l’affondo di Curzio Malaparte
Curzio Malaparte, nel suo libro La rivolta dei santi maledetti, pubblicato nel 1921, presentò una tesi critica nei confronti di Luigi Cadorna e della gestione militare che aveva portato alla disfatta di Caporetto.
Malaparte offrì una prospettiva diametralmente differente, concentrandosi sulle debolezze per così dire strutturali dell’esercito italiano, anziché attribuire la colpa ai singoli soldati – i “santi maledetti”.
Sostenne quindi che la sconfitta di Caporetto fosse dovuta agli errori strategici e tattici del comando militare e, nello specifico, alla rigidità e l’intransigenza di Cadorna nel pianificare e condurre le operazioni militari.
Inoltre, in controtendenza rispetto alla pubblicistica del tempo, sottolineò le difficili condizioni in cui le truppe avevano combattuto, anche per via della mancanza di un adeguato supporto logistico.
Per di più – contrariamente a Cadorna, che incolpava la propaganda “disfattista” e “pacifista” – Malaparte suggerì che un altro, grave problema era stato quello di mantenere alto il morale delle truppe.
Una delle tesi centrali di Malaparte, perciò, era la seguente: il rifiuto di attribuire la colpa della sconfitta ai soldati – “maledetti” dal nemico e dai generali, ma “santi” per aver salvato la patria – e poi mettere in discussione di Cadorna, che, a suo giudizio, aveva cercato un capro espiatorio invece di assumersi la responsabilità dei propri fallimenti.
L’opera brillante di un uomo fuori dal comune
La rivolta dei santi maledetti di Curzio Malaparte – volume concepito come opera di deliberato intento polemico – ebbe una storia editoriale del tutto particolare.
Venne infatti stampato nel 1921 presso una tipografia di Prato, con il provocatorio titolo Viva Caporetto!, e subito sequestrato dalla censura; poi ripubblicato nel 1923 con titolo attuale, e di nuovo bloccato dalle autorità; per poi apparire – in forma definitiva e integrale – solo nel 1980.
Come ha scritto lo storico Francesco Perfetti nella prefazione dell’edizione Passigli, il libro resta, ancora oggi, “una testimonianza di prima mano sulla Grande Guerra”.
Un volume che intendeva cambiare la percezione sulla disfatta di Caporetto e, allo stesso tempo, dando voce ai drammi e alle sofferenze dei soldati, “far capire l’entità dell’ignoranza, dell’indifferenza e della rassegnazione della fanteria, in gran parte composta di contadini, nei confronti delle ragioni politiche e ideali della guerra”.
Resta perciò l’opera brillante di una personalità estrosa e poliedrica: uno scrittore che, se nel tempo ha suscitato clamore e dibattiti, anche per via della posizione ambigua nei confronti del regime fascista, ha senz’altro lasciato un segno nel tormentato Novecento italiano.