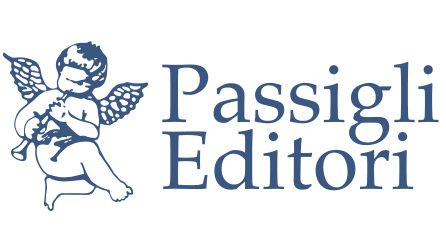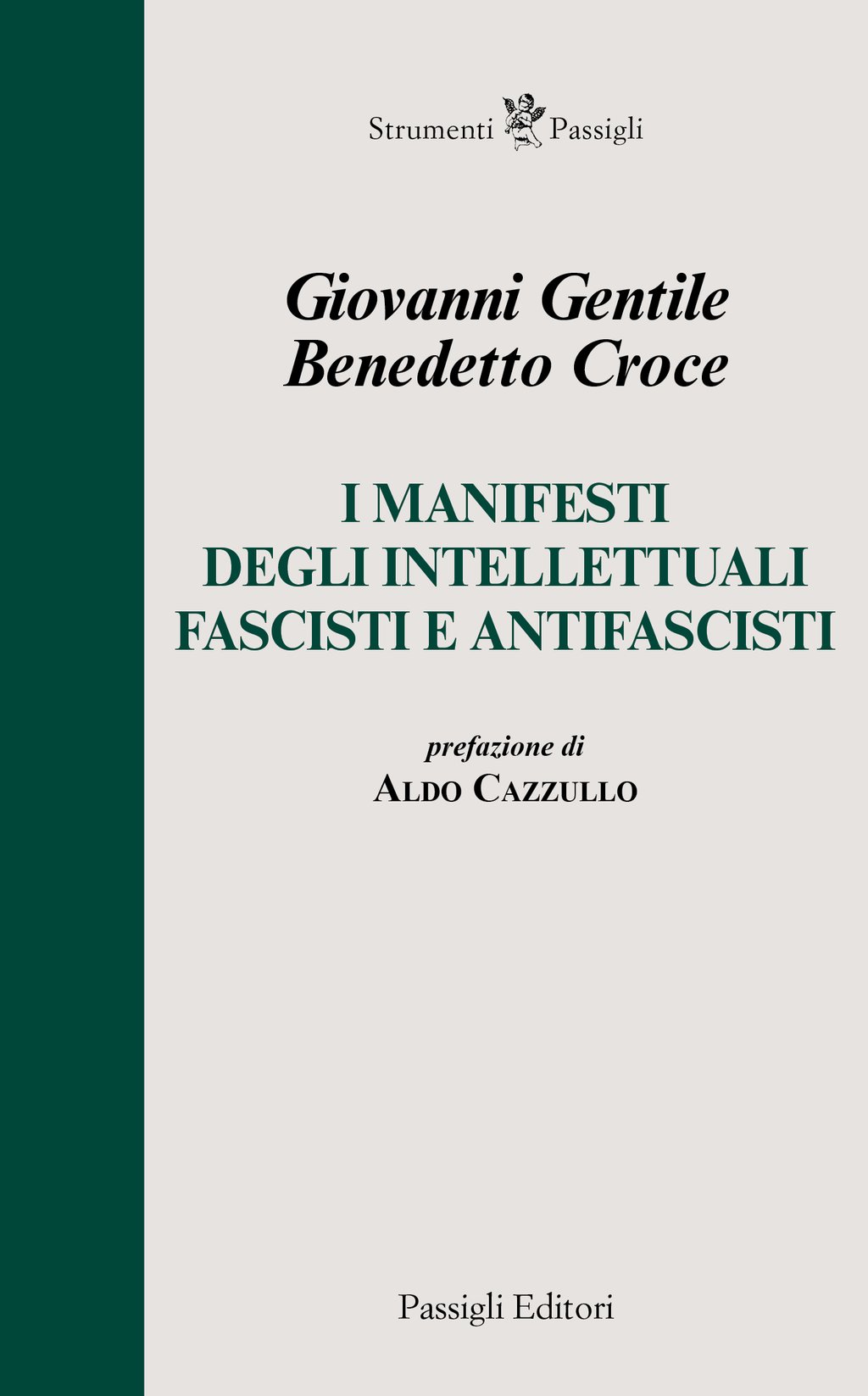Libri sul Fascismo: ecco, in catalogo, i due manifesti con prefazione di Aldo Cazzullo
Nella primavera del 1925 il dibattito pubblico e politico italiano – già segnato dall’ascesa del Fascismo – si caratterizzò per l’aperta contrapposizione di due fazioni avverse e irreconciliabili, riunite attorno gli scritti di due filosofi: il Manifesto degli intellettuali fascisti, redatto da Giovanni Gentile, e il Manifesto degli intellettuali antifascisti, steso invece da Benedetto Croce.
Due uomini figli del loro tempo, accomunati da passioni e interessi culturali convergenti, come la la storia della filosofia e il risorgimento italiano, non privi di divergenze e punti di vista differenti, ma soprattutto – e irrimediabilmente – divisi dal giudizio, opposto, sul Benito Mussolini e il Fascismo.
Per rievocare quella delicata fase storica, e tornare a riflettere sulla storia d’Italia e i suoi snodi principali, abbiamo pubblicato i due Manifesti nella collana Strumenti Passigli con la prefazione di Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, il cui recente volume su Mussolini ha avuto ampia fortuna.
Approfondiamo insieme!
Libri sul Fascismo: i due Manifesti
Di libri sul Fascismo e Mussolini ce ne sono ormai tanti, alcuni anche molto attenti all’analisi politica e alla contestualizzazione storica.
Più in generale, poi i migliori libri sul Fascismo – dopo anni di ricerche, indagini e confronti – sono riusciti a dar conto di un fenomeno complesso ed enormemente articolato che nel volgere di pochi anni, facendo della violenza politica una delle sue cifre distintive, conquistò il potere e cancellò la democrazia in Italia; trovando in questo, peraltro, l’appoggio più o meno convinto di una parte non marginale della classe dirigente pre-fascista.
Eppure, senza mettere in secondo piano le grandi sintesi e il valore dei saggi divulgativi, tornare ai documenti di allora può rivelarsi – e in effetti si rivela, spesso – un ottimo modo per ricostruire i vari passaggi, dare contesto ai singoli eventi e calarsi nel clima politico e culturale del tempo.
Da qui la scelta di pubblicare, arricchendo il nostro catalogo, il Manifesto degli intellettuali fascisti – comparso il 21 aprile 1925 sul quotidiano Il Popolo d’Italia – e il Manifesto degli intellettuali antifascisti – apparso invece il 1° maggio 1925, in risposta al primo, sul quotidiano Il Mondo.
La sfida tra Gentile e Croce
I due testi espressero, al tempo, due posizioni opposte e conflittuali, così come sancirono la spaccatura – altrettanto divisiva, sia a livello personale che professionale – tra Giovanni Gentile e Benedetto Croce.
Il primo, Gentile, filosofo di fama internazionale, instancabile promotore culturale e già ministro dell’Istruzione nel primo governo Mussolini, si schierò allora a favore del Fascismo al potere, visto come una necessità storica in divenire che, con forti legami col passato risorgimentale, avrebbe consentito la rigenerazione morale e spirituale dell’italia.
Il secondo, Croce, esponente di rilievo della corrente dell’idealismo, bastione del liberalismo conservatore e a lungo punto di riferimento per lo stesso Gentile, si levò invece contro il Fascismo, prendendo le distanze dal moto fascista (che pure in precedenza aveva guardato con benevolenza) e divenendo, così, il faro intellettuale dell’opposizione legale.
Il Manifesto degli intellettuali fascisti e l’ideologia del Fascismo
Il Manifesto degli intellettuali fascisti è il primo documento ideologico con cui, una parte non marginale della cultura italiana, aderì al Fascismo pubblicamente.
Il testo esaltò il ruolo dello stato nella vita civile, nell’ambito di un superamento netto del liberalismo tradizionale, fece riferimento a un rinnovato spirito nazionale e, più in generale, si propose di influenzare tutta la cultura italiana del dopoguerra.
In calce recava nomi di assoluto rilievo: a parte Gentile, anche Giuseppe Ungaretti, Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Pirandello, Curzio Malaparte, Ugo Ojetti, o ancora Ardengo Soffici.
Inoltre, si criticavano apertamente le forze d’opposizione antifascista, definendole “detriti del vecchio politicantismo italiano”, e si metteva in chiaro che, sotto il regime guidato da Mussolini, celebrato come la pietra angolare di un futuro radioso, queste ultime sarebbero rimaste “sempre al margine delle forze politiche effettivamente operanti nella nuova Italia”.
Così, descrivendo il Fascismo come “un movimento recente ed antico dello spirito italiano, intimamente connesso alla storia della Nazione italiana”, si auspicava, o meglio si presagiva la scomparsa della dissidenza in Italia, dal momento che qualsiasi programma alternativo a quello promosso dal governo sarebbe stato “compreso nel programma fascista”, compattando la nazione per la prima volta dopo il Risorgimento.
Una visione totalizzante, e totalitaria, che avrebbe segnato la storia del paese.
Il Manifesto degli intellettuali antifascisti: contro il Fascismo in Italia
Scritto per reazione al primo Manifesto, il Manifesto degli intellettuali antifascisti – spesso molto citato ma anche poco letto – non contiene includenti denunce nei confronti di Mussolini, a riprova della debolezza dell’opposizione.
Né riporta Fascismo e libertà, generiche frasi contro il Fascismo, dato che la resistenza al governo era il frutto di un’ampia e ben più corposa riflessione sulla vera natura del potere fascista (un’ardita mescolanza di vecchio e nuovo, capace di produrre lo stesso concetto di totalitarismo).
Nell’opinione di chi sottoscrisse il testo, come Giovanni Amendola, Luigi Einaudi, Luigi Salvatorelli, Gaetano Salvemini, Sibilla Aleramo o ancora Eugenio Montale, Fascismo e libertà erano in aperta contrapposizione: l’uno puntava alla distruzione della seconda.
Anzi, era possibile annoverare tra simboli del Fascismo, ovvero tra gli elementi caratterizzanti della dottrina del Fascismo, proprio il disprezzo e l’avversione per i corpi teorici e le ideologie collettive che, dal XIX secolo in avanti, seguendo la strada già battuta dell’illuminismo, erano proiettati alla promozione e all’estensione della libertà (o meglio, delle libertà: politiche e civili).
Proprio insistendo sul principio della libertà, e rivendicando l’eredità del Risorgimento, si scrisse senza mezzi termini di non voler aderire alla nuova “religione”, cioè del Fascismo. Nel dettaglio:
“Per questa caotica e inafferrabile ‘religione’ noi non ci sentiamo, dunque, di abbandonare la nostra vecchia fede: la fede che da due secoli e mezzo è stata l’anima dell’Italia che risorgeva, dell’Italia moderna; quella fede che si compose di amore alla verità, di aspirazione alla giustizia, di generoso senso umano e civile, di zelo per l’educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per la libertà, forza e garanzia di ogni avanzamento”.
Libri sul Fascismo: un volume per studiare la storia d’Italia
Il quadro storico appena rievocato rende chiaro, a nostro giudizio, che di libri sul Fascismo – di buoni libri sul Fascismo – l’Italia ha ancora bisogno.
Non solo perché le interpretazioni evolvono grazie a un processo dialettico di continuo arricchimento, superamento e perfezionamento, ma anche perché, col passare degli anni, mutano le sensibilità dei contemporanei e cambia anche il modo in cui si osserva il passato; l’approccio con cui ci si rivolge alla storia, dunque, e le ragioni per le quali, prima di guardare avanti, si decide di guardare indietro.
Per queste ragioni abbiamo arricchito il nostro catalogo pubblicando, nella collana “strumenti Passigli”, I Manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti, facilmente acquistabile anche in versione E-book.